
…E la vita non continua.
Un anno dopo la prima a Torino, Habitat – Note personali di Emiliano Dante rivive ad Annecy, poi a Istanbul (International Architecture and Urban Films Festival, dal 2 al 9 ottobre prossimi), e ci si augura in altri festival e sale, arricchito di sei preziosi minuti che ne specificano il paesaggio interiore. Giusto una breve aggiunta che arriva dopo i titoli di coda, integri, della prima visione e versione. Un epilogo cupo e «disfattista» su come si è evoluta (involuta) quella non-storia (proprio nel senso di negazione di storia, oltre che di geografia, riservata ai protagonisti) iniziata il 6 aprile 2009, il fatidico giorno del terremoto aquilano, quello con il numero maggiore di film, diretti e indiretti, fiction e non-fiction, fuori schema e fuori schermo, mai ispirati da e ad un sisma.
Un terremoto-emblema, infatti. Il segno dei tempi. Corrotti, deprivati, privatizzati, terminali. E un segno del non tempo, nuova percezione del vuoto, ad esso incatenato concatenato. L’aggiunta di quei dolorifici minuti estende con naturalezza l’idea di tempo immobile, senza passato né futuro, totalmente annidato nel film, e tuttavia in feroce scorrimento, scivolo angoscioso verso l’insignificante, la morte. «Tra le macerie il passato è più passato, simultaneamente più visibile e più inservibile. E nei progetti C.A.S.E., questi prefabbricati già fatiscenti costruiti dopo il terremoto in mezzo al nulla, il presente è più presente: senza uno ieri e senza un domani». É l’autore a dichiararlo.
Dante si era rivelato con il blues di Into the Blue (2009), sullo stesso tema e alla stessa maniera ecceduto. Un film ironico, sincopato, ispirato, dove il terremoto aquilano diveniva il pre-testo per mettere in luce una precaria condizione giovanile fatta a pezzi, mostrata nelle sue purulente interiora, scoperchiata come gli stessi edifici aquilani, tetto ingannatore sgretolatosi fuori e dentro. Opera dolorosamente zen, dove l’autore si esponeva in prima persona, raccontando la sua avventura in tendopoli, il senso del vuoto espresso con altrettanto sentimento svuotato dell’assurdo. Niente a che vedere con i piagnistei carini e ipocriti del cinema italiano giovane (o meno giovane) su giovani (o meno giovani).
Habitat è il funereo e risentito «Cinque anni dopo» di Into the Blue. Invano policentrico, perché ormai ognuno «si chiude nel proprio guscio». Resta un sestetto di voci e di esseri che cercano di restare uniti oltre che umani. I tre ex compagni di tenda più le consorti. Non più giovani(ssimi), non più colti di sorpresa, immersi nelle rovine di un «limbo» che sa più di waste land eliotiana (anche all’Aquila, «aprile è il mese più crudele») popolata da personaggi beckettiani. L’autore si autodefinisce un Krapp tra i nastri. Che si ostina a disegnare, enumerare, sezionare, indagare, toccare. Sono quelle immagini su cui pone di continuo frecce direzionali, lyrics di canzoni, scritte, schizzi, linee, conti alla rovescia, e che miniaturizza nel monitor del computer, smontandole nel momento stesso in cui stanno avvenendo: tempo nel tempo, tempo del tempo.
Un paradosso ribadire la natura cinematografica, tecnica, di un documentario, ciò che per statuto (rimesso in discussione) si offre come spaccato di realtà. Più che straniamenti o meta-cinema, sono tentativi di rendere meno astratta la superficie del vedere. Quasi a voler riscrivere il corso del (non) tempo che bagna, mai due volte, l’intero film. Lo schermo diventa una tabula concreta, il journal dell’invisibile a cui dar forma. Per rendere il virtuale (non del film: delle nostre esistenze) ancora corpo; e nel tentativo di (ri)dare all’e(s)terno presente (dello spettacolo-vita) un passato e un futuro rimossi. Un esempio moderno di film come oggetto concreto. Da scolpire, materia tattile da rimodellare, esperienza dell’esperienza, film del film, immagine-habitat, che lo accomuna all’altro Habitat [Piavoli] (2013) di Claudio Casazza e Luca Ferri e ad Ananake (2015) di Claudio Romano, ulteriori opere-casa scolpite nel/dal tempo. Ognuno détour(nement) di un nuovo antico sentire in movimento, capace di dare forma (habitat?) alla mente, al puro cogito.
Il design registico di Habitat è elegantissimo, lo contraddistingue un touch architettonico, l’occhio allenato, mai alienato, alla storia dell’arte, mobilissimo ma fermo, luogo d’incontro tra tristezza e bellezza, forme annientate e forme (ri)edificate, disegno grafico come interiorità ulteriore. Tra quel passato e quel futuro che la storia (in tutti i sensi) nega. Sottraendosi agli estetismi facili come ai carrelli di Kapò. Benché non manchino bianchi abbacinanti (luce, neve, sfondi) e buio post-atomico (reso ancor più buio dalla luce), con corredo di camera-car, jump-cut, accelerazioni, inserimenti, dissolvenze, sovrimpressioni, immagini-cuscino alla Ozu, foto fisse, giochi di specchio e la musica extradiegetica che diventa diegetica, quando l’immagine si ridimensiona nel computer di Emiliano che monta il film. Anche un’intermission e una metamorfosi in cartoon, disegno di un’alienazione in agguato. Il volto umano risponde però intenso allo sguardo profondo di chi lo riprende.
Con lucido dolore e uno sguardo non riconciliato neppure con sé stesso, l’autore rivela sin dall’incipit la propria intenzione di scendere agli inferi. Da quelle immagini in negativo degli edifici sventrati, preludio all’Ade, tremolanti come lo fu la terra aquilana, si accede, effetto Nosferatu, a un altro mondo. Il cane psicopompo è lì, guardiano tra l’aldilà e l’al-di-qua, dio ferino e ferita, animale epilettico (lo sapremo più in là). Lo troviamo nell’appartamento dell’autore (un «regalo» di Berlusconi), dopo che lo si è visto in strada, messaggero dei morti, custode della distruzione. Scodinzola e fa festa al suo padrone, che accetta volentieri l’intercessione dei cani guida (nel film ce ne sono altri due, entrambi privi di una zampa). La depressione, il fallimento, l’impermanenza delle cose (a fronte della permanenza apodittica dell’immagine ufficiale), gli attaccamenti, l’amore più freddo della morte, e persino un po’ di masochismo, popolano i giorni/gironi senza scampo di questo nuovo Inferno di (Emiliano) Dante.
Il carattere onirico e visionario del film è ribadito da quel Perché fai questi sogni, Emiliano?, titolo del prologo. Il sogno, l’incubo, è sempre il terremoto, improvviso dopo il bacio da una donna, contrapposto segno vitale. Le tre storie d’amore del film sono una risposta al dolore e al morire. Alessio e Gemma, Paolo e Roberta, Emiliano e Valentina. Tutti loro rivivono in sogno il crollo. Ci si chiede se qualche storia, in progress con il film, sarebbe sbocciata così rapidamente se non ci fossero state le scosse fatali. E chissà, se senza di esse, si sarebbe altrettanto rapidamente conclusa. Qui nascere diventa meno forte che morire. La vita di Paolo cambia più per la morte della madre, che non per la condizione di neo-papà.

Nell’epilogo, Emiliano confessa di non sognare più il terremoto, da quando Habitat è stato presentato al TFF. Il suo film-parete era (è) proprio una rielaborazione scritta del lutto, un agire in immagini, una dura e pervicace resistenza. In memoria di Noemi. Ancora. Ragazza vittima del terremoto, che Emiliano teme di dimenticare poco a poco. «Appena dimentichiamo, la nostra storia diventa più insignificante». Constatando come, altrettanto lentamente, l’Aquila e gli aquilani siano divenuti parte del fondale, non più centro. Sostituiti, in quelle case di C.A.S.E., da un avatar d’imposta normalità, in quanto «per essere dignitoso non devi sembrare quello che sei», cioè un terremotato: status da dissimulare come «l’età e la calvizie». Eliminare i container per edulcorare il dramma, restyling della catastrofe. Com’è noto, e non solo per via di Sabina Guzzanti, il post-terremoto è stato soprattutto un evento mediatico. Lo si ammette esplicitamente: «È stato come vedere le cose in TV».
La vera catastrofe del sisma è stato di accadere in un momento di grande dimenticanza collettiva e di spettacolo come unica forma di realtà. Ecco perché il film finisce per diventare (anche) altro, le note personali sulla Terra mutata, oltre che sui terremotati. Il padre di Emiliano, lo storico Umberto Dante, parla dei secoli che passano in un attimo, in situazioni come questa. «La vita umana è qualcosa di effimero, è poca cosa quando ci si imbatte nel tempo». Ed è chiaro che potrebbe riferirsi anche alla nostra epoca a-storica (sappiamo che di dopostoria parlava infatti Pasolini, più di 40 anni fa). Periferizzati nei fragili appartamenti berlusconiani, a 14 km dalla città vera e propria, i non abitanti si recano al centro commerciale, non-luogo di una non-città, reinventato come piazza principale, il posto «dove si incontra altra gente, dove si incrociano gli sguardi»: «non per comprare qualcosa, ma per vedere qualcuno, per semplice solitudine». È il caso di aggiungere che avviene lo stesso anche dove il terremoto non c’è stato? Idem quando si parla di quadri realizzati (da Paolo) e non venduti, di professioni surreali (di Alessio) da inventarsi per necessità, di fughe e rientri per senso di colpa. Oppure perché «aveva più senso stare male a L’Aquila che a Terni». Estensione del movimento tellurico.
Siamo davvero soltanto all’Aquila? O nell’Italia intera? Nel mondo? In quella Bruxelles, simbolo e fortezza dell’Impero d’Europa, dove Antonio vive anche lui in un appartamento semidiroccato? Il terremoto è uno stato dell’essere. Del non essere, hic et nunc. Tutto è ormai parziale e incompleto: aggettivi con i quali Dante ammette di voler rappresentare il capoluogo abruzzese. Quel rituale collettivo della fiaccolata, popolata da ectoplasmi, diventa una sconsolata metafora di cosa significhi adesso non voler stare al gioco. E svela con disperazione angosciata i fantasmatici tentativi di (r)esistere e protestare oggi.
In Habitat lo sguardo sul terremoto contempla di continuo la non epoca in cui è inserita la tragedia. Il suo non essere più tempo. Un «dramma urbano più che naturale». I colori bellissimi e sereni della natura indifferente, l’azzurro del cielo, il verde delle piante, i frutti e un insetto li si vede un attimo soltanto. Un film così deve per forza essere in bianco e nero: sono quelli i non colori adeguati per la giungla d’asfalto, lo diceva pure Fritz Lang. Grigi e bianchi a sfidare la produzione e gli enti locali, che vorrebbero un film di speranza: «la parola preferita dai politici di mestiere, perché nella sua vaghezza neutralizza ogni discorso e lo rende poco più che un cerimoniale».
Prima di chiudere, Dante li inganna in quel colore e quella serenità ritrovati, ancora per un istante, nel giardino della basilica di Collemaggio. Atmosfera rilassata, un pallone, gente che sembra in pace con sé stessa. Ma ecco l’indicazione che appare sull’edificio, e una scritta (in inglese), a dirci che il tetto non c’è più, non c’è ancora. Ironia feroce. Comprendiamo che quelle cifre esibite per tutto il film – non solo i minuti scanditi a ritroso della sua durata, ma pure i 14 chilometri di distanza, il riferimento ai 70.000 decentrati, i 15 minuti di vita della piccola Laura, i 5 anni dopo, i 6 minuti ancora – sono una replica senza sconti al trionfalismo definitivo delle versioni ufficiali, della società dei dati-spettacolo. Uno schiaffo all’ottimismo democratico.
Nessuna tele-visione trasformerebbe la ricostruzione, espressa da una gru, in drago alato, ossia nella rivelazione del caos; né avrebbe il coraggio tetro di alludere, nell’ultimissima immagine del film (versione estesa), a qualcosa di innominabile più volte evocato. Esprimendo pienamente il sentimento apocalittico di una new land di «morti in anticipo». Figuriamoci se osasse poi mostrarci, all’inizio di una storia d’amore, quella vissuta in tempo reale dallo stesso regista, la luce nullificante verso cui la nuova coppia si dirige. È il chiarore saturo dell’entropia. La casa-habitat che non ci attende. Quel che è avvenuto dopo, Valentina lo dirà nell’epilogo 2015. •
Leonardo Persia
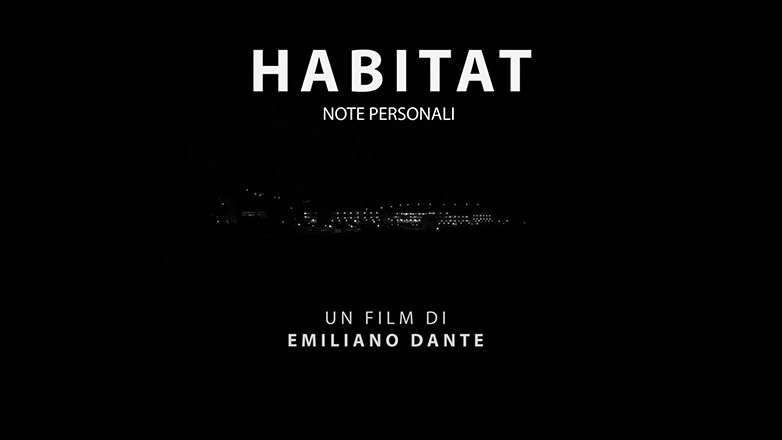
Habitat – Note personali
Regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, musiche, disegni e animazioni: Emiliano Dante
Produttore esecutivo: Valentina Soccorsi
Additional cameramen: Paolo De Felice, Valentina Soccorsi
Cantante solista: Valentina Soccorsi
Cast (come se stessi): Alessio Di Giannantonio, Paolo De Felice, Emiliano Dante, Gemma Giuliani, Roberta Lucrezi, Valentina Soccorsi (e Antonio Sforna, Sabrina Bologna, Antonello Ciccozzi, Suor Oliva Lombardi, Umberto Dante, Odoardo Tomassi)
Produzione: Dans Acro – Digital Artisans, C.U.M.
Formato di ripresa e proiezione: Full HD
Colore: B/N e Colore
Paese: Italia
Anno: 2014
Durata: 55′ / 61′
/// dansacro.org
L'articolo che hai appena letto gratuitamente a noi è costato tempo e denaro. SOSTIENI RAPPORTO CONFIDENZIALE e diventa parte del progetto!






