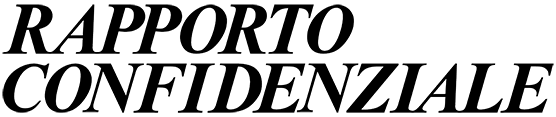La Chambre verte, voragini dell’epilogo
a cura di Vincenzo Palermo
«Quando facevo il critico, pensavo che un film per essere riuscito dovesse esprimere simultaneamente un’idea del mondo e un’idea del cinema; La regola del gioco o Quarto Potere rispondevano bene a questa definizione. Oggi a un film che vedo domando di esprimere sia la gioia di fare il cinema, sia l’angoscia di fare il cinema e mi disinteresso di tutto ciò che sta in mezzo, vale a dire di tutti i film che non vibrano».
François Truffaut
Bastano dodici fotogrammi al secondo per dare l’illusione ottica del movimento, funziona così il cinema. Secondo Bergman è un nulla nel nostro nervo ottico, uno shock: ventiquattro quadratini illuminati al secondo e tra di essi il buio. L’arte cinematografica, tuttavia, come ricorda il sommo cineasta è un’esperienza che tocca soprattutto le corde più intime dell’anima, sfiorando delicatamente la coscienza diurna e penetrando lo spazio crepuscolare dell’umano sentire. La settima arte è carnalità e anima, vita e morte. Un film esprime gioia o angoscia, non dovrebbe mai lasciare indifferenti, anzi, deve vibrare e rappresentare l’unità onnicomprensiva capace di stringere simultaneamente il mondo e l’idea stessa della cinematografia. Tutto ciò che sta in mezzo è da dimenticare, perché ogni film, per essere “vibrante” deve somigliare ad un pendolo che oscilla tra inquietudini e consolazioni.
Di questa idea di cinema “vivo” e pulsante Truffaut ne ha fatto un manifesto e lo terrà presente soprattutto per uno dei suoi film più cupi ed estremi, La chambre verte (1978), in cui la voragine dell’epilogo coincide con un’ascesi ritualizzata e dove il simbolo, elevato a pura intuizione, diventa filosofia della Memoria.
Truffaut, dopo aver interpretato L’enfant sauvage (1970), veste i panni di un misantropo ammalato della vita, un “virtuoso del necrologio”, come lo definisce il collega che lavora con lui al giornale Le Globe, che preferisce la riflessione solitaria alla vita consumata in atti vuoti e di forma, sociali e pulsionali. Incapace di superare il dolore per la perdita della moglie Julie, edifica per lei un sacrario nella propria dimora, colmo degli oggetti a lei appartenuti e delle sue foto e ritratti. A seguito di un incendio riesce a portare in salvo alcuni oggetti e decide di restaurare una vecchia cappella in rovina (dov’è sepolta la moglie) per creare un simbolico spazio da dedicare a tutti i suoi cari estinti.

La camera verde rappresenta il luogo di culto inviolato consacrato a Julie, mentre la cappella è l’altare dei morti, di cui parlò Henry James nell’omonima opera e che il cineasta francese visualizza come spazio edenico del ricordo, illuminato da ceri e candele che producono ombre fantasmatiche e rischiarano quasi a giorno quadri, effigi mai dimenticate e oggetti.
Nel tempio, fra i simboli di un recente passato, ci sono i ritratti del già citato Henry James, di Cocteau e di Marcel Proust, elementi di un gioco di corrispondenze letterarie che definisce la filosofia di Truffaut per contrasto: Proust riflette sull’oblio, il regista, al contrario, lo allontana in virtù di un’eternizzazione feticistica. Il “corpo” degli oggetti e le figure sulle tele bloccano il tempo in un presente eterno in cui il protagonista, Julien Davenne, vorrebbe affogare per sempre e tornare così alla vita, quella dei suoi morti. La memoria di noi cinefili, invece, torna alla famosa scena del cero acceso sotto la foto di Balzac da Antoine Doinel ne Les Quatre Cents Coups (1959) e le correspondences diventano quindi autocitazioni, o meglio, esempi di autoreferenzialità: Antoine e Julien, sono maschere dello stesso regista.
Il temperamento malinconico di Julien Davenne, “uomo della folla” e revenant deciso a sconfiggere l’oblio dell’eterno, fa pensare alle mesmerizzazioni di Edgar Allan Poe che vuol ridare vita ai defunti, a Henry James che li fa parlare presentificandoli su simbolici altari, a Freud che descrive la conseguenza inevitabile di chi non riesce a superare il periodo di lutto. La ricerca del protagonista esclude la transitorietà esistenziale perché il tempo di Julien è definitivo: egli rifiuta di abbandonare la defunta moglie e ricrea un simbolico luogo liturgico, spazio morale feticistico composto da oggetti senza più vita, riflessi mortuari continuamente surrogabili ma bloccati in un presente inaccessibile e sempre uguale, non mutevole ma eterno. L’irruzione improvvisa di una donna nella vita solitaria del protagonista reca con sé l’illusione di un amore mai sbocciato, perché Cécile, che lo aiuta a custodire la cappella, lo ama, ma per possederlo, forse, non dovrebbe essere viva.
“Amare i morti contro la vita”, questa la massima di un uomo che rifiuta il presente come oggetto d’esperienza, la sua formazione passa infatti per un oggetto ormai assente e, quando nel finale si lascia morire rifiutando conforto e cibo, Cécile accende un ultimo cero nella cappella, quello dell’uomo che ha sempre amato, ma la cui conquista si è resa inaccessibile. Il cerchio si chiude, Julienne ha raggiunto ora l’ascesi verso il regno oltremondano e, come chi “non ne può più della vita”, può ritornare nell’oblio che non sarà mai perdita, perché le candele accese ritualmente da Cécile lo ricorderanno in eterno.
Il film più sottovalutato di Truffaut narra la storia di un pensatore solitario che ama la fine più dell’inizio, la morte più della vita, la voragine dell’epilogo più che la vertigine dell’inizio. •
Vincenzo Palermo

La Chambre verte
Titolo italiano: La camera verde
Regia: François Truffaut
Sceneggiatura: François Truffaut, Jean Gruault dai romanzi di Henry James: L’autel des morts, La bête dans la jungle, Les amis des amis
Musiche: Maurice Jaubert
Fotografia: Néstor Almendros
Montaggio: Martine Barraqué
Scenografie: Jean-Pierre Kohut-Svelko
Costumi: Monique Dury et Christian Gasc
Produttore: François Truffaut
Interpreti: François Truffaut (Julien Davenne), Nathalie Baye (Cecilia Mandel), Jean Dasté (Bernard Humbert), Patrick Maléon (Georges), Jeanne Lobre (Mme Rambaud), Antoine Vitez (secrétaire de l’évêque), Jean-Pierre Moulin (Gerard Mazet), Serge Rousseau (Paul Massigny), Jean-Pierre Ducos (Prêtre dans la chambre mortuaire), Annie Miller (Geneviève Mazet), Nathan Miller (le fils de Geneviève Mazet)
Produzione: Les Films du Carrosse et Les Productions Artistes Associés
Distribuzione: United Artists
Colore: Eastmancolor
Rapporto: 1.66:1
Negativo: 35 mm
Processo fotografico: sferico
Proiezione: 35 mm
Lingua: francese
Paese: Francia
Anno: 1978
Durata: 94′
L'articolo che hai appena letto gratuitamente a noi è costato tempo e denaro. SOSTIENI RAPPORTO CONFIDENZIALE e diventa parte del progetto!